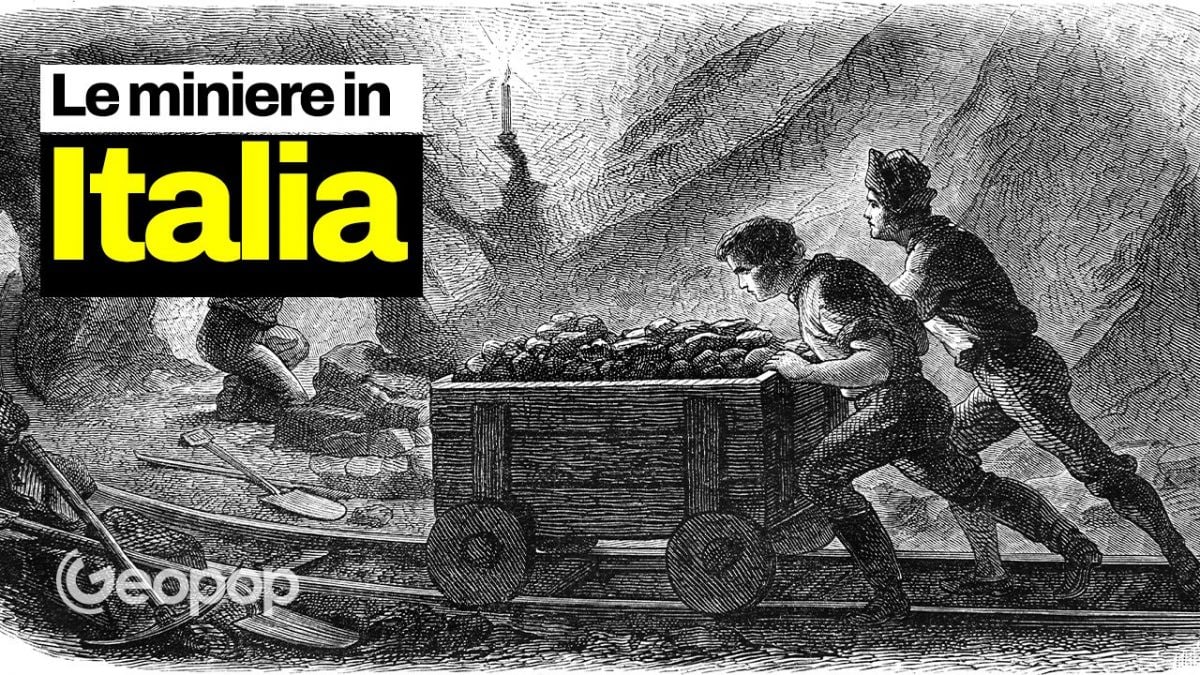
Ormai in Italia sempre meno gente lavora all'interno delle miniere. Non per mancanza di volontà o di capacità, ma perché la maggior parte di quelle esistenti è stata chiusa nel Novecento. Prima di questo periodo gli oltre 3000 siti minerari erano capillarmente distribuiti su tutto il territorio nazionale e si estraevano in grandi quantità carbone, zinco, rame, argento e ferro, solo per dirne alcuni. Ma quali sono stati i principali poli estrattivi dei decenni passati? E dove e cosa si estrae oggi in Italia?
Miniere d'Italia del passato
Da un punto di vista storico, la Sardegna è una tra le regioni italiane più importanti per quanto riguarda l'attività estrattiva, soprattutto nel Sulcis-Iglesiente (zona Sudovest dell’isola). In quest'area erano presenti decine e decine di miniere, tra cui Monteponi e Montevecchio, dove le mineralizzazioni di piombo, argento e zinco sono insediate nelle formazioni geologiche carbonatiche che, con oltre 500 milioni di anni di età, sono tra le più antiche rocce d’Italia.

Per quanto riguarda il ferro, alla fine dell'Ottocento questo era in gran parte prodotto sull'isola d'Elba dalle miniere di Rio e Calamita: durante il 1800 l’estrazione si aggirava intorno alle 7000 tonnellate annue; durante la Prima guerra mondiale la produzione schizzò alle stelle, arrivando anche a circa 800.000 tonnellate di ferro all’anno.

Parlando di oro invece, una tra le principali miniere è quella di Chamousira in Valle D’Aosta: fu scoperta nel 1899 ed è rimasta in attività fino agli anni Ottanta dello scorso secolo. In questo caso le rocce metamorfiche, caratterizzate da due filoni auriferi, risalgono a poco più di 30 milioni di anni fa. Questo tipo di giacimento è "primario" e ciò significa che l’oro che si estrae lì, si è anche formato lì. Ricordiamo infatti che esistono anche giacimenti auriferi di tipo "secondario": in questi casi casi l’oro può essere strappato via da un giacimento primario e trasportato dai corsi d’acqua.
La fine di un'epoca
Oggi la maggior parte di queste miniere, come quelle di ferro della Valle D’Aosta, dell’isola d’Elba e quelle di carbone nel Sulcis, in Sardegna, sono state abbandonate essenzialmente per due motivi:
- costi di produzioni elevati rispetto ad altri Paesi;
- basse concentrazioni di minerali utili.
Con la fine del secolo scorso si è quindi conclusa l'epoca dei giacimenti minerari. Di questa pratica oggi resta perlopiù il ricordo, testimoniato dai tesori di archeologia industriale sparsi su tutto il territorio nazionale. Pensate che alcune miniere sono state addirittura convertite in veri e propri musei come quella della Guia (in Valle Anzasca) o quella di Montevecchio (in Sardegna).

L'attività estrattiva in Italia oggi e le miniere attive
Cosa estraiamo oggi in Italia? Se da un lato l'estrazione mineraria è ridotta all'osso, dall'altro il nostro Paese ha ancora un luogo di primo piano nell'estrazione dei cosiddetti "materiali di seconda categoria", o "materiali da cava": si tratta di un termine generico all'interno del quale rientrano materiali come calcari, marmi, graniti, argille, sabbie, travertini ecc

Parlando delle miniere più importanti d'Italia, uno tra i principali esempi che possiamo fare è quello della pomice. Questa roccia vulcanica leggerissima ed estremamente porosa è esportata in tutto il mondo, tanto che la metà della produzione globale ha luogo nel nostro Paese e, in particolar modo, a Lipari. È il maggior produttore al mondo di minerali feldspatici (silicati), e riesce a raggiungere un quarto dell’intera produzione globale. Un altro fiore all'occhiello della produzione italiana è il marmo, specialmente quello bianco tipico delle Alpi Apuane (il famosissimo marmo di Carrara).

Secondo i dati ISTAT riferiti al 2018, in Italia esistono 4518 siti estrattivi autorizzati e, di questi, 2169 sono attivi. Sempre nel 2018, per dare ancora un paio di numeri, abbiamo estratto circa 166 milioni di tonnellate di risorse minerarie: parliamo principalmente di calcare, travertino, gesso, arenaria (quasi 70 milioni di tonnellate) e sabbia e ghiaia (59 milioni di tonnellate).



;Resize,width=578;)


;Resize,width=727;)



