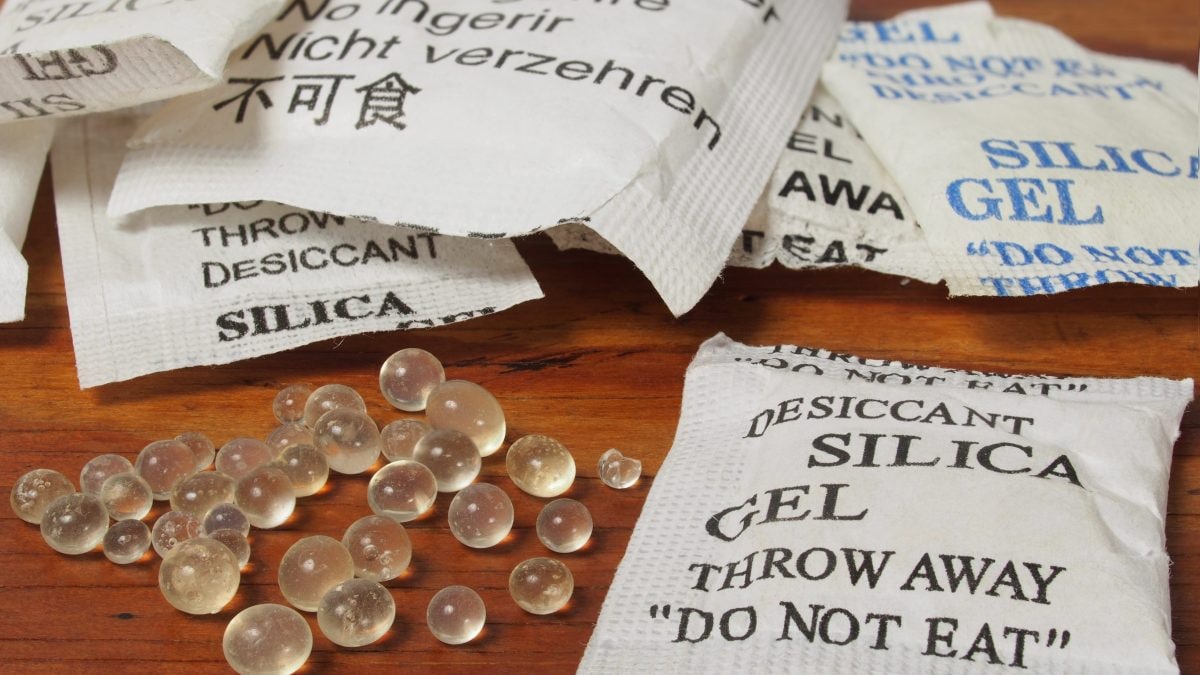
Il gel di silice è quel materiale in granelli che troviamo, tra le altre cose, nelle famose bustine “DO NOT EAT”, spesso infilate nelle scatole delle scarpe e negli imballaggi in generale. La sua funzione è tanto “semplice” quanto importante: assorbire l’umidità. Proprio per questa sua capacità disidratante viene utilizzato anche in altri ambiti, dove è necessario mantenere asciutto qualcosa, che siano componenti elettroniche, libri o appunto vestiti e scarpe. Ma come fa a “catturare” così bene l’acqua presente nell'aria? La risposta risiede nella sua struttura chimica. Il gel di silice non è altro che silice amorfa che si dispone in un vero e proprio reticolo poroso. È come se fosse una minuscola rete piena di buchi (i pori) disposti qua e là pronti per acchiappare molecole di acqua, altrettanto piccole. Oltre alla presenza dei pori, grazie ad alcuni gruppi chimici capaci di legare l’acqua, la stessa superficie del gel contribuisce ad assorbire l’umidità. In questo modo il gel di silice riesce a trattenere grandi quantità di H2O sulla propria superficie senza diventare molle o sciogliersi. In sostanza, i suoi trucchi sono: tanti pori, tanta superficie e tanti punti in cui l’acqua si attacca. In questo modo, riesce a trattenere fino al 40% del suo peso. È un meccanismo semplice, stabile ed efficace, che rende il gel di silice uno dei migliori disidratanti tecnici in circolazione.
Cos’è e come funziona il gel di silice: una gigantesca superficie nascosta
A prima vista sembra sabbia, ma da un punto di vista chimico, il gel di silice è biossido di silicio amorfo, una struttura di silice non cristallina, cioè non ordinata e regolare nello spazio, ma disordinata e “caotica”. Questo disordine è proprio ciò che permette di avere una struttura porosa capace di eliminare l’umidità dell’aria; per ottenerla, si sfruttano particolari procedimenti chimici chiamati “sol–gel”. Questi processi creano una rete tridimensionale irregolare con micropori, di dimensioni inferiori a 2 nanometri, e mesopori, grandi fino a 50 nanometri. È proprio questa moltitudine di cavità irregolari a rendere il materiale così efficace: un grammo di gel di silice può avere anche 700 m² di superficie interna, quasi quanto due campi da basket schiacciati dentro un cucchiaino! Non è impressionante?
Questa enorme superficie è la vera “arma segreta”: più area superficiale significa più spazio per ospitare molecole d’acqua. Grazie all’architettura disordinata della silice amorfa, l’acqua può infilarsi ovunque e trovare un punto che la trattiene. È un po’ come entrare in una casa con mille mensole: più mensole hai, più cose puoi appoggiare. Qui ogni mensola è un poro.
Perché l’acqua rimane attaccata: la chimica dell’adsorbimento
Ora entriamo nel cuore del fenomeno: l’adsorbimento. E no, non abbiamo sbagliato a scrivere: parliamo di aDSorbimento e non di aSSorbimento (come una spugna che ingloba l’acqua). È un vero e proprio fenomeno chimico-fisico che potremmo definire una sorta di “adesione superficiale”. In poche parole, quando un gas raggiunge la superficie di un materiale solido, le molecole di gas – di H2O presente nell'aria come vapore acqueo nel nostro caso – possono “appoggiarsi” sullo strato superficiale del materiale.

Assorbimento (destra, in arancione): le molecole vengono inglobate nel materiale, come una spugna assorbe acqua
Questo fenomeno può essere più o meno forte in base alle interazioni che si formano tra il materiale solido e il gas con cui entra in contatto: per esempio, molecole gassose che si adsorbono senza particolari interazioni con il materiale, possono facilmente "desorbirsi" e volare di nuovo via; se invece si formano legami chimici, sarà molto difficile, se non impossibile, rompere il legame tra il materiale e il gas.
Nel caso del gel di silice, l'adsorbimento avviene grazie all'interazione di alcuni gruppi chimici presenti sul reticolo e l'acqua presente nell'aria. La superficie del gel, infatti, è piena di gruppi chiamati “silanoli” (Si-OH), formati da un atomo di silicio e un gruppo ossidrile (OH) che hanno una forte affinità con le molecole di H2O. La presenza di questi gruppi superficiali permette la formazione di un legame a idrogeno che non lascia più fuggire l’acqua. Anche se non sono forti come dei legami covalenti che si creano in una reazione chimica vera e propria, l'interazione tra i due gruppi è comunque forte abbastanza per rimuove l’umidità dall’aria e non lascia più andare via (a meno che non intervengano fattori esterni come il calore).
Combinate insieme, la formazione dei legami superficiali e l’elevata superficie porosa, spiegano perché il gel di silice riesce trattenere fino al 40% del suo peso in acqua, un risultato notevole per un materiale così semplice e stabile.

Credit: Stéphane Mons, CC BY–SA 3.0, via Wikimedia Commons
Cosa succede dopo?
La cosa interessante e curiosa è che, una volta saturato (cioè quando la superficie si è riempita di acqua), il gel di silice non “suda” acqua e non si deforma rammollendosi. Rimane solido, rigido e sicuro anche a pieno carico. Questo è uno dei motivi per cui viene scelto per prodotti delicati come farmaci, dispositivi elettronici, obiettivi fotografici, alimenti secchi e perfino collezioni museali.
Dopo la saturazione il gel può essere rigenerato semplicemente riscaldandolo. Il calore rompe i legami a idrogeno con l’acqua permettendole di evaporare; una volta raffreddato, il gel torna pronto a riutilizzare la sua rete di pori.
In pratica, il gel di silice funziona come un custode silenzioso contro l’umidità: non fa rumore, non si muove, non cambia forma, ma continua a catturare acqua all’infinito come se avesse un superpotere. E tutto questo grazie a strutture invisibili a occhio nudo, pori e legami “trappola” per la fastidiosa umidità.


;Resize,width=767;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)

