
Quando premete il tasto “Start” su una fotocopiatrice, in pochi secondi si verifica qualcosa di sorprendentemente complesso. All'interno della macchina si attiva un processo fisico e chimico basato sull'interazione tra luce, cariche elettriche e materia: la xerografia, invenzione del 1938 di Chester Carlson, che ha rivoluzionato il modo di riprodurre i documenti. In termini semplici, una fotocopiatrice crea una copia perfetta di un'immagine o di un testo sfruttando le cariche elettriche e la sensibilità alla luce di particolari materiali. Tutto inizia con una carica elettrostatica su una superficie chiamata fotoricettore, prosegue con la proiezione dell'immagine originale, l'adesione della polvere di toner alle aree caricate e il trasferimento di questa immagine su un foglio di carta che, infine, viene riscaldato per fondere in modo permanente il toner. In pochi istanti, il documento è pronto.
Questa tecnologia, apparentemente banale nell'uso quotidiano, ha sostituito processi lenti e laboriosi come la carta carbone o il ciclostile, aprendo la strada alla produzione rapida e a basso costo di copie di qualsiasi documento. Oggi le moderne fotocopiatrici digitali integrano scanner, stampanti laser e microprocessori che consentono di collegarsi a reti informatiche, inviare fax e perfino convertire un testo stampato in file digitali modificabili tramite riconoscimento ottico dei caratteri, il cosiddetto OCR (Optical Character Recognition). Comprendere come funziona una fotocopiatrice vi permetterà di apprezzare meglio questo strumento e dare una sbirciatina dentro una delle più eleganti applicazioni della fisica elettrostatica al servizio della vita quotidiana.
Cos’è la xerografia: storia e origine della tecnica sviluppata da Chester Carlson
La storia della fotocopiatrice risale al 1938, quando Chester Carlson, un avvocato dell'ufficio brevetti di New York, cercava un modo per riprodurre documenti senza ricorrere a sostanze chimiche liquide e senza doverli riscrivere a mano. Il principio base su cui si fonda il funzionamento della fotocopiatrice è la xerografia, dal greco xeros (secco) e graphé (scrittura), cioè “scrittura a secco”. Il nome fu scelto alla fine degli anni ’40 da una piccola azienda americana, la Haloid, poi divenuta la celebre Xerox Corporation. Proprio la Xerox, su come Carlson arrivò a sviluppare la tecnica su cui è basato il funzionamento delle fotocopiatrici, spiega:
Carlson chiamò inizialmente il processo “elettrofotografia”. Il processo si basa su due fenomeni naturali: l'attrazione dei materiali con carica elettrica opposta e la migliore capacità di alcuni materiali di condurre l'elettricità quando esposti alla luce. Carlson ideò un processo in sei fasi per trasferire un'immagine da una superficie ad un'altra sfruttando questi fenomeni.
Le sei fasi del processo di fotocopiatura
Vediamo più da vicino il processo in sei fasi a cui fa riferimento Xerox. Il cuore di ogni fotocopiatrice è un componente chiamato fotoricettore, una superficie sensibile alla luce che può essere realizzata come tamburo rigido o come cinghia flessibile. È rivestito da un sottile strato di materiale fotoconduttivo, cioè un composto che si comporta da isolante quando è al buio ma che diventa conduttore se esposto alla luce.
- Caricamento: al buio, una tensione elettrica molto alta viene applicata vicino a sottili fili metallici o a un rullo, generando un campo elettrico che provoca la ionizzazione delle molecole d'aria. Gli ioni, cioè le particelle elettricamente cariche, si depositano sulla superficie del fotoricettore, generando un campo elettrico.
- Esposizione: l'immagine del documento viene “scritta” sul fotoricettore. Nelle moderne fotocopiatrici digitali questo avviene tramite un raggio laser modulato o un sistema di LED che proiettano l'immagine in modo preciso. Nelle macchine analogiche, invece, era la luce riflessa dal documento a colpire direttamente sul fotoricettore. Le zone del fotoricettore illuminate perdono parte della carica elettrica, mentre le aree rimaste in ombra la conservano: il risultato è un'immagine elettrostatica latente, invisibile ma pronta a essere sviluppata.
- Sviluppo, dove la protagonista è la polvere di toner. Si tratta di minuscole particelle (in genere tra 5 e 10 micrometri di diametro) formate da una miscela di resine, pigmenti e additivi plastici. Il toner viene mescolato con piccole sfere metalliche che lo caricano per triboelettricità, un effetto fisico dovuto allo sfregamento tra materiali diversi, lo stesso che genera l'elettricità statica. Le particelle di toner, ora elettricamente cariche, vengono attratte dalle zone del fotoricettore rimaste cariche e vi aderiscono, ricreando in forma visibile l'immagine del documento. Nelle fotocopiatrici a colori questo passaggio avviene quattro volte, una per ciascun colore base – ciano, magenta, giallo e nero – che si combinano per produrre la gamma cromatica finale.
- Trasferimento: l'immagine in polvere passa dal fotoricettore alla carta. Questo avviene mettendo a contatto il foglio con il fotoricettore e applicando una carica elettrica di segno opposto a quella del toner. L'attrazione elettrostatica fa sì che la polvere si stacchi dal fotoricettore e aderisca al foglio, riproducendo l'immagine. Subito dopo, un'altra scarica controllata neutralizza la carta, che viene separata dal fotoricettore senza danni e prosegue il suo percorso all'interno della macchina.
- Fusione: il toner (che fino a quel momento era solo poggiato sulla superficie della carta) viene reso permanente. Il foglio attraversa due rulli: uno riscaldato e uno di pressione. Il rullo caldo scioglie le particelle di toner, mentre il secondo rullo le preme saldamente contro le fibre della carta. Il risultato è un'immagine nitida e resistente, che è a tutti gli effetti fusa con le fibre del foglio e, quindi, non può più essere rimossa.
- Pulizia: dopo ogni stampa, sul fotoricettore rimane sempre una piccola quantità di toner residuo. Per evitare che queste particelle interferiscano con la copia successiva, viene eseguita la pulizia, solitamente tramite un apposito rullo di pulizia.
Naturalmente, il processo appena descritto avviene in pochi secondi risultando del tutto invisibile all'utente che mette in funzione la fotocopiatrice.
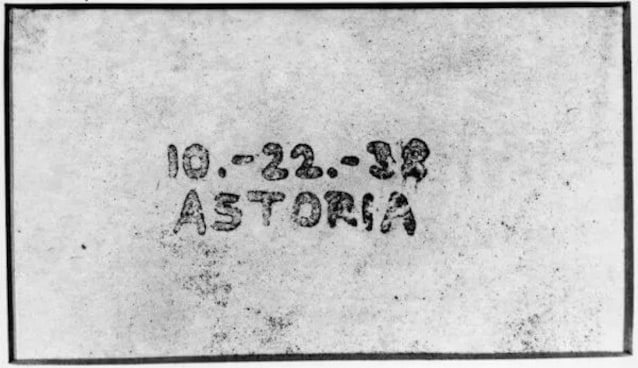
L'evoluzione delle fotocopiatrici
Con il trascorrere dei decenni le fotocopiatrici hanno avuto un'evoluzione e, negli anni ’90, sono diventate digitali. In queste ultime, infatti, uno scanner ottico acquisisce l'immagine del documento e la memorizza in formato digitale. Da quel momento, il laser non riproduce più direttamente la luce riflessa del documento, ma scrive l'immagine sul tamburo pixel per pixel, come se “stampasse” la copia da un file. Questo sistema consente di ottenere più copie da una sola scansione, migliorare automaticamente la qualità dell'immagine e collegare la macchina a una rete.
Oggi le fotocopiatrici multifunzione sono vere e proprie stazioni di lavoro: possono stampare, scansionare, inviare documenti via fax o e-mail e archiviare copie in formato PDF. In uffici e scuole sono spesso dotate di ADF (Automatic Document Feeder), un alimentatore automatico di fogli che gestisce copie fronte-retro e fascicolazione automatica, a volte con pinzatura o rilegatura dei documenti. Le versioni domestiche, decisamente più compatte, adottano la stessa logica ma meccaniche più semplici.
;Resize,width=767;)
;Resize,width=578;)
;Resize,width=767;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)

