;Resize,width=638;)
Uno degli elementi che hanno contribuito a fare grande Roma sono state sicuramente le sue strade. La rete viaria dell'impero è stata la più sviluppata e complessa che il mondo occidentale avesse mai visto fino a quel punto della sua storia, con i tracciati delle strade impiegati ancora durante il Medioevo e l'età moderna. Ancora oggi, molte delle principali vie di comunicazione europee seguono le antiche strade dell'impero. In alcuni casi, dei tratti delle vie romane sopravvivono ancor oggi, dimostrando il livello dell'ingegneria romana. Scopriamo come furono realizzate.
Com'erano fatte le strade romane e come venivano costruite
Nonostante l'importantissimo ruolo commerciale e civile che le strade avevano nell'impero, non bisogna mai dimenticare che il primo scopo per il quale queste vennero costruite era di natura militare. Nella maggior parte dei casi, infatti, le vie romane venivano costruite dalle legioni stesse. Una buona strada era necessaria per spostare facilmente e velocemente gli eserciti in caso di necessità. Solo successivamente gli assi viari divennero vettori commerciali e di comunicazione. All'occorrenza quindi, i legionari erano operai e ingegneri.

Per realizzare una strada, era prima di tutto necessario individuare il luogo preciso dove questa sarebbe dovuta passare. Ciò era compito di figure professionali come gli ingegneri e gli agrimensores, antenati dei moderni geometri. Per collegare un punto con un altro, normalmente si sceglieva la via più breve e diritta possibile, ma dove ciò non fosse possibile, le capacità ingegneristiche e logistiche delle legioni permettevano di adattare il terreno o di aggirare senza problemi eventuali ostacoli, tramite la costruzione di ponti o gallerie.

Una volta scelto il tratto, si provvedeva alla delimitazione della larghezza della strada, che avveniva tramite la realizzazione di un profondo scavo (fossa) e di due terrapieni laterali. Il riempimento della fossa naturalmente poteva variare a seconda dei materiali disponibili sul luogo, ma generalmente si caratterizzava per una stratificazione di diversi materiali. Sul fondo si cercava di applicare una base solida, nota come statumen, composta da grossi blocchi di pietra legati fra loro all'occorrenza da malta cementizia. Questo primo strato molto resistente avrebbe garantito durabilità alla struttura.
Successivamente, al di sopra dello statumen, veniva poggiato uno strato noto come rudus, composto da inerti come vecchi laterizi rotti o pietrame di medie dimensioni, tenuto assieme da un legante. Questo strato, vista la sua composizione, avrebbe permesso di drenare le acque piovane che si sarebbero infiltrate dall'alto. Al di sopra del rudus veniva apposto il nucleus, composto da ghiaia e sabbia, che avrebbe contribuito al drenaggio e alla stabilità dell'ultimo strato, quello superficiale, noto come pavimentum.
Il pavimentum veniva realizzato con pietre squadrate e lavorate appositamente per rappresentare il piano calpestabile della strada. Dovevano essere resistenti, semplici da mantenere e all'occorrenza facilmente sostituibili. Venivano apposte infine le pietre miliari, che riportavano la distanza in miglia fra le località, e le pietre confinarie, che segnavano i limiti delle unità amministrative all'interno dell'impero. L'insieme di questi quattro stati, ognuno pensato con uno scopo ben preciso, permetteva alle strade di essere durature e resistenti.

Tratti di strada romana ancora visibili
I tratti di strade romane sopravvissuti fino ad oggi e ancora visibili in tutta Europa e nel bacino del Mediterraneo sono innumerevoli. Eccone si seguito alcuni:

Un tratto ben conservato della Via Appia, che collegava Roma a Brindisi, è visibile nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, a Roma sud, integrato all'interno del Parco Regionale, uno dei parchi urbani più estesi d'Europa.

Ad Aquileia, in Friuli, è possibile ammirare alcuni tratti della Via Gemina, la strada che collegava l'antica metropoli aquileiese con Emona, l'antica Lubiana, capitale della Slovenia.

La Via Traiana era assieme alla Via Appia una delle più importanti dell'Italia meridionale. Permetteva di collegare Benevento e Brindisi.


;Resize,width=767;)
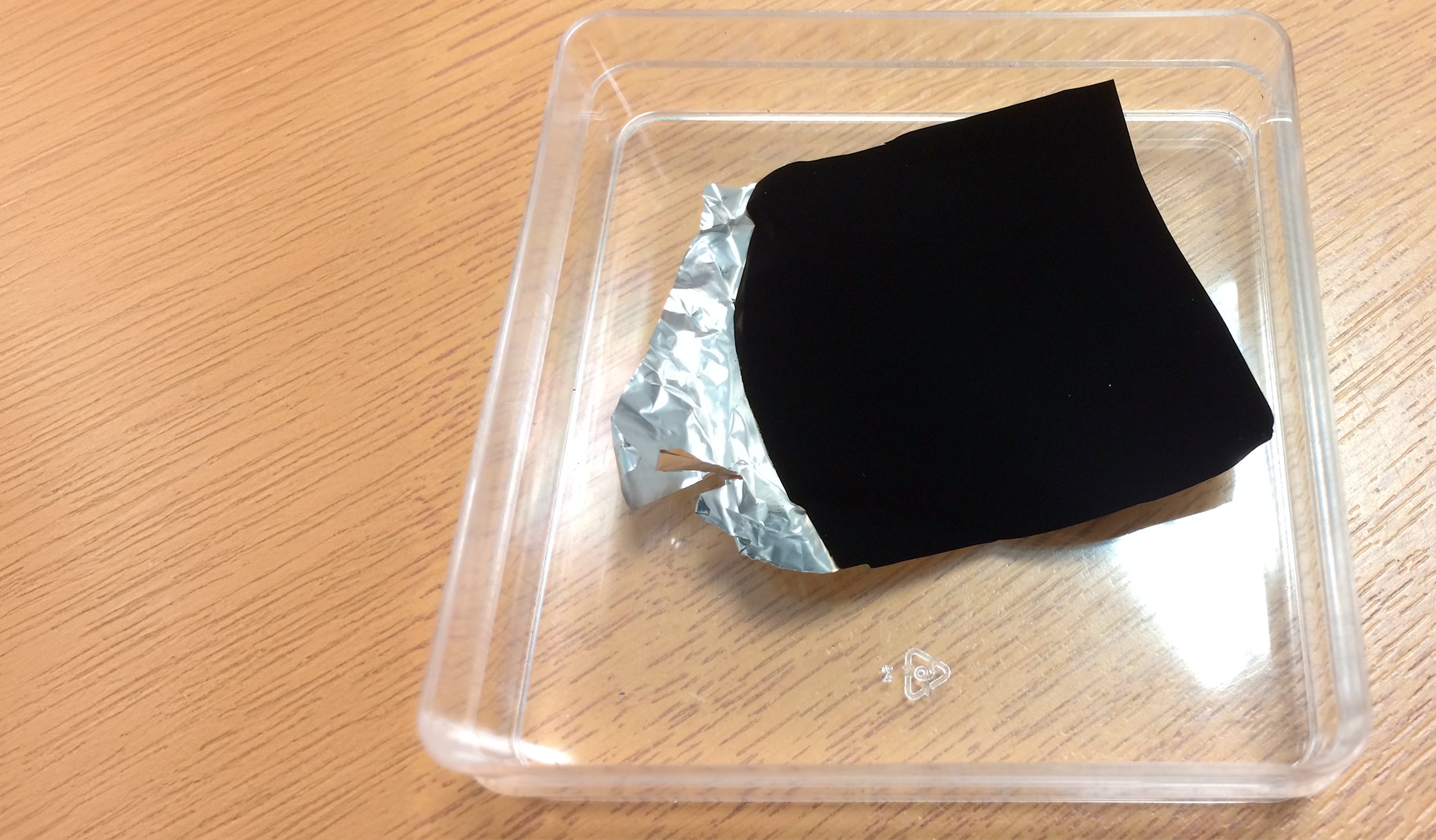;Resize,width=712;)
;Resize,width=270;)
;Resize,width=270;)
;Resize,width=270;)
;Resize,width=270;)

