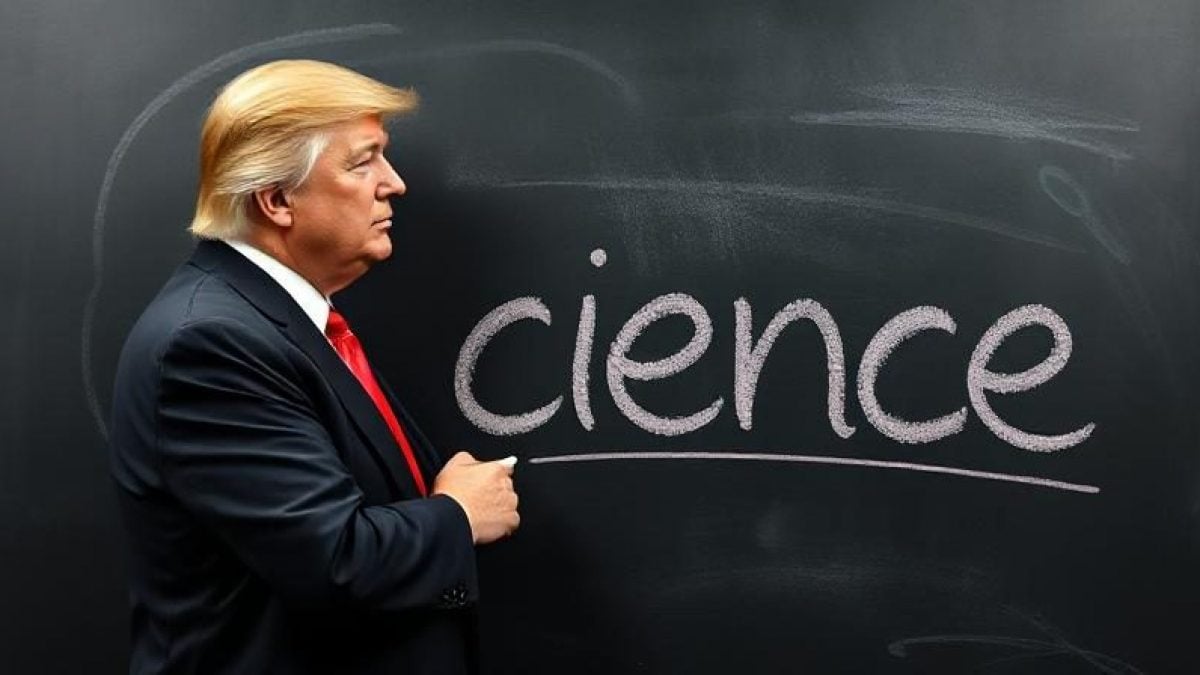
Se c’è un tratto distintivo della politica di Donald Trump nei confronti della scienza, è la tendenza a ridimensionarla, marginalizzarla e, in alcuni casi, a ignorarla del tutto. Dai tagli alla NOAA fino all’uscita dagli Accordi di Parigi e dell’OMS, la sua amministrazione ha adottato una linea che considera la ricerca più come un ostacolo che come un’opportunità. Ma perché? Perché un Paese che ha costruito la propria supremazia economica e tecnologica anche grazie alla scienza, dall’era spaziale fino alle rivoluzioni digitali, oggi la tratta come un problema?
La scienza non crea profitto immediato
La scienza non è neutrale agli occhi della politica. Non perché abbia un’agenda ideologica, ma perché produce dati, e i dati possono scombinare equilibri economici e politici. La ricerca scientifica funziona con tempi lunghi, raccoglie prove, studia fenomeni complessi e, a volte, rivela verità scomode. Se uno studio mostra che un settore industriale contribuisce all’inquinamento o che una scelta politica ha effetti negativi sul lungo termine, chi governa ha due opzioni: accettare la realtà e intervenire, oppure minimizzare e screditare la fonte.
L’amministrazione in diverse occasioni ha dimostrato di preferire la seconda via. Dalla limitazione dei fondi alla NOAA ai tentativi di ridimensionare il ruolo dell’EPA (Environmental Protection Agency), la strategia è stata chiara: ridurre il peso della scienza nel dibattito politico ed economico, soprattutto quando i dati interferiscono con una visione orientata al profitto immediato.
Il caso emblematico dei licenziamenti al NOAA voluti da Trump
La NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), istituita nel 1970, è l’agenzia che monitora il clima, gli oceani e i fenomeni atmosferici estremi. I suoi dati sono cruciali per prevedere uragani, tempeste e altri eventi che possono avere impatti devastanti sulle comunità e sull’economia. Ma la NOAA è anche un pilastro nella ricerca sul cambiamento climatico. I suoi studi contribuiscono a definire le strategie globali per la riduzione delle emissioni di CO₂ e per l’adattamento ai mutamenti climatici. Ed è qui che entra in conflitto con una politica che ha spesso negato la crisi climatica.
Nei primi mesi del 2025, l’amministrazione Trump ha tagliato centinaia di posti di lavoro nella NOAA, riducendo drasticamente la capacità degli Stati Uniti di monitorare l’atmosfera e gli oceani. Una decisione che non ha solo conseguenze scientifiche, ma anche economiche: settori come l’agricoltura, il turismo e l’energia dipendono da dati climatici affidabili per pianificare le proprie attività.
Industria e scienza: alleati, non nemici
Sia ben chiaro, questo non è un attacco all’industria. Il progresso economico si basa anche su ricerca, innovazione e competitività. Le aziende hanno bisogno di efficienza, strategie di mercato e ritorni sugli investimenti. Questo è il motore del sistema economico, che piaccia o no. Il punto è che la scienza segue un’altra logica. Non lavora su trimestri finanziari, o su quadrienni di governo, ma su decenni di osservazioni, analisi e sperimentazioni. E i risultati spesso emergono nel lungo periodo, senza un ritorno economico immediato.
Nel caso della NOAA, pensiamo alla meteorologia: senza modelli atmosferici sviluppati in decenni di studio, oggi non avremmo previsioni affidabili. Pensiamo alle ricerche sulla biodiversità marina: senza dati raccolti in anni di monitoraggio, non sapremmo come gestire in modo sostenibile le risorse oceaniche. Tagliare la ricerca perché non porta profitti immediati è un errore strategico, non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia stessa.
Le conseguenze di una politica cieca
Ridurre il peso della scienza nelle decisioni politiche significa esporre il paese a rischi evitabili.
- Senza dati climatici affidabili, intere economie locali possono essere colpite da eventi estremi non previsti.
- Senza ricerche indipendenti, le strategie industriali rischiano di basarsi su informazioni incomplete o di parte.
- Senza investimenti nella ricerca, gli Stati Uniti perdono terreno nella competizione globale sull’innovazione.
E questo ha un costo, economico e sociale. Perché se c’è una cosa che la scienza insegna, è che i problemi ignorati oggi diventano crisi domani. La scienza è un investimento, non un lusso.
Il vero problema non sono i tagli alla ricerca scientifica, ma la mentalità che li guida
La riduzione del personale della NOAA, l’uscita dagli Accordi di Parigi, l’abbandono dell’OMS sono senza dubbio decisioni sbagliate, ma il vero aspetto su cui riflettere è che rappresentano una tendenza preoccupante; rappresentano una mentalità in cui la scienza viene percepita come un freno, la pianificazione a lungo termine come un ostacolo e la realtà come qualcosa di adattabile alle esigenze politiche del momento.
Questi non sono semplici provvedimenti amministrativi, ma segnali di un modo di governare che antepone in maniera estrema, molto più estrema rispetto a quanto avvenuto fino a oggi, il consenso immediato e il ritorno economico rapido alla conoscenza e alla preparazione per il futuro.
Alla base c’è una logica pericolosa: l’idea che la scienza sia utile solo se immediatamente funzionale a interessi politici o industriali. La ricerca scientifica non risponde ai cicli elettorali o alle strategie di mercato. Risponde al metodo, ai dati e alla realtà. E ignorarla non evita le conseguenze. Le rimanda, rendendole peggiori.
;Resize,width=767;)

;Resize,width=767;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)
;Resize,width=727;)

